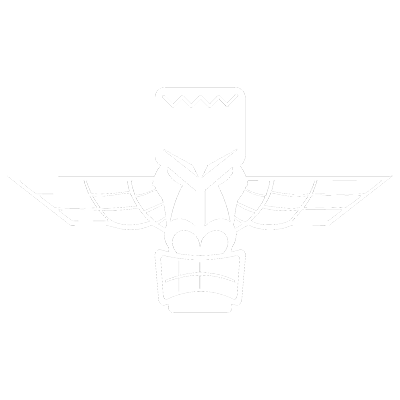Martedì, 20 gennaio 2015
Siamo stati a vedere l’NBA, i Brooklyn Nets contro gli Houston Rockets.
La partita è un evento, il pubblico affluisce a poco a poco, il palazzetto a pianta ovale è un tripudio di ristorantini, di cibo take away, di birre e negozi sportivi. Il tabellone luminoso sopra il parquet scandisce il tempo che manca all’inizio dell’incontro e di colpo tutti i posti vengono riempiti. Quello che accade è frenetico, succede sempre qualcosa: viene cantato l’inno (e via il cappello e tutti in piedi, mano sul cuore), poi comincia la partita e nelle sospensioni del gioco, per falli o time out, sui maxi schermi giganti vengono proiettate le immagini salienti di quanto appena accaduto, poi nelle pause tra i tempi arrivano le cheer-leaders con coreografie pacchiane e la lotteria sancisce chi tra i possessori dei biglietti godrà dell’upgrade del proprio posto e la musica è a volume serissimo e si balla un po’ ovunque e poi i giganti del basket ricalcano la scena e riprendono a mordere il parquet.
Durante la partita, Silvia, ex giocatrice di basket in serie B e quindi mia Virgilio della palla a spicchi, mi spiegava, abbastanza sorpresa, come in pratica le due squadre non difendessero il gioco avversario. È un gioco tutto votato all’attacco, lo spettacolo esplode, i punteggi sono elevati e i gesti tecnici che ammiravo mi strappavano urletti isterici e applausi entusiasti. Eppure in quel tripudio di fuochi d’artificio, qualcosa non mi tornava. Silvia sostiene che il basket europeo è sì meno spettacolare, ma molto più raffinato. Io, cresciuto a pane e catenaccio, concordo con lei.
La falange romana ha conquistato il mondo sbaragliando il nemico battaglia dopo battaglia, grazie a un modello che noi abbiamo introiettato nello sport, che potremmo tranquillamente definire «l’arte di non prenderla, innanzitutto». Il che significa, prosaicamente, lavoro di squadra, coordinamento tra i ruoli, difesa del compagno perché difendendo lui difendo chi mi difenderà, nonché uno sviluppatissimo e animalesco intuito, ascrivibile al misterioso senso del «sapere approfittare». La difesa non è una limitazione dello spettacolo, è uno spettacolo di per sé, meno avvincente, ma non per questo meno funzionale. La falange, compatta, resisteva perché con le sue unità replicava la testuggine, rendendo i tanti singoli un unico organismo. Il nemico sbatteva contro quella corazza e non riusciva a perforarla, così si sfiancava nei tentativi che immancabilmente andavano a vuoto e, proprio quando la stanchezza irrigidiva le membra, ecco l’orrore: la testuggine diventava lupo e azzannava le carni con furia atavica, mordeva alla giugulare, beveva il sangue versato. L’Impero avanzava sui cadaveri che non seppero scardinarne il meccanismo di difesa. È un po’ anche il trionfo del passivo-aggressivo, se vogliamo, ma la storia va oltre la psicoanalisi da diario.
C’è questo qui a NY, mi faceva notare Silvia, il singolo è assolutamente votato all’aspetto performativo. Come nella Messa gospel, in cui tra canti e balli e sermoni, è tutta una preghiera festosa e ciò che manca è proprio il silenzio. Ecco il punto: manca il silenzio a NY, non come assenza di suono, ma come eredità e confronto culturale, quello che si ritrova in tutto, nelle pause tra le sirene della polizia e dopo le virgole nelle frasi, nel fondo del caffé appena bevuto e nelle tasche vuote quando i piccioli finiscono. Manca quella condizione che, banalmente, potrei tradurre come «attesa», muta come un abbandono incondizionato.
La partita dell’NBA è una gara magnifica ma non tra due squadre. È un uno-contro-tutti (e, in questo meccanismo, un tutti-contro-tutti, in cui il singolo deve dimostrare di essere più forte di tutti gli altri, compagni compresi).
Harden, dei Rockets, è il giocatore più forte in campo. Mancino, impugna subito le redini dell’incontro. Quando i Nets provano a tenergli testa – non a tenere testa a tutti i Rockets, ma proprio a lui – ecco che Harden lascia che il proprio mancino si scateni: un tiro da tre, lento e dalla parabola altissima, che termina così come ogni conclusione da tre dovrebbe terminare, con la palla che buca il canestro senza neanche toccare la rete. E poi infila un’altra conclusione da tre, e un’altra. Harden è una furia. Segna 26 punti in una frazione e mezzo, ne fa segnare altri 40 ai suoi compagni, decidendo il gioco, imponendo i ritmi, demolendo i Nets. E i Nets sono tutto, fuorché una squadra. Hanno provato a rientrare in partita e l’hanno fatto nell’unico modo conosciuto: i colpi dei singoli. La rabbia, il furore agonistico, la cattiveria era quella di singoli militari che tentano l’assalto al forte. Dall’altra parte, Houston limitava i danni lasciando fare al proprio cecchino. Un’azione è stata emblematica: all’inizio del terzo tempo, i Nets attaccavano proprio come un bambino incaponito attaccherebbe un muro per romperlo a pallonate. A testa bassa e senza raziocinio. Non erano un corpo, erano tanti e, prova e riprova, il muro rimandava indietro le pallonate. Perché il muro non cadrà mai per un pallonata. E, se vuole, il muro può fare male. Questo è quanto è accaduto: un giocatore dei Nets prova a schiacciare e viene stoppato. L’umiliazione è già di per sé enorme, anche perché viene innescato immediatamente il contropiede. Il distacco è quasi abissale, diciotto punti e mancano sette minuti alla fine del terzo tempo. È Harden ad avere la palla ed è solo nella metà campo avversaria. Ora schiaccia, pensano tutti e lo pensano così intensamente che nessuno gli va incontro, nessuno va a difendere, la sconfitta è ormai certa e la partita è andata. Errore. Non si stanno facendo i conti con il muro. Perdere è un conto, venire polverizzati, un altro. Ed è qui che il singolo dimostra che sta lottando contro chiunque possa fargli ombra, perché è in ciò che è gratuito e privo di necessità che brilla l’individualità. Harden, da solo con tutto il campo spalancato e nessun avversario attorno, non va a schiacciare. Fa di peggio. Harden, solo come un predicatore nel deserto, si ferma sulla linea, palleggia con flemma, tira da tre. La palla assume una traiettoria perfetta, senza sbavature. Fossimo nel campo della poesia, diremmo che è una carezza, o un colpo di sciabola diritto nel cuore, che è lo stesso. Ovviamente, la palla fa canestro, il nemico è schiantato, l’Impero del sé, che Harden rappresenta, colpisce ancora.
(nella foto di Silvia, l’ingresso del Barclays Center)