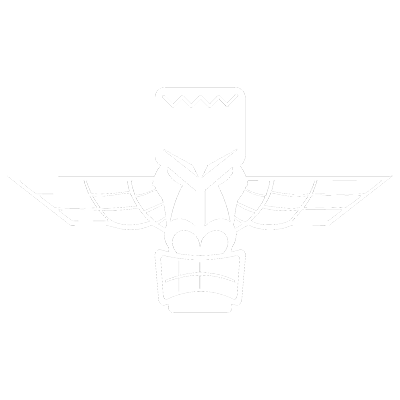Brighton Beach è proprio come me l’avevano descritta: piena di russi, con insegne in cirillico, pietanze russe vendute a bordo strada, dialoghi in russo. Mi dirigo verso l’Oceano, per raggiungere dalla spiaggia Coney Island. Lou Reed rivendicava con orgoglio la propria appartenenza a questi luoghi e cantò in più dischi la relazione consumata qui con la travestita Rachel\Tommy, metà messicana e metà indiana, sua musa e compagna nella metà degli anni settanta.
La giornata è fredda, il mio venticinque aprile è passato qui, in questo tratto di sabbia tra oceano e palazzoni, dove persone portano a spasso i cani, genitori spingono carrozzine e latini sfrecciano su biciclette trasformate in chopper.

Delle vecchie giocano a carte sedute su una panchina. Hanno l’età che avrebbe mia nonna oggi, se fosse ancora viva. Fumano il sigaro e sbattono il dorso delle carte con violenza, come ogni anziano che si rispetti in tutte le taverne del mondo. Parlano con quella cadenza così riconoscibile da rendere il russo un vero e proprio marchio, con quelle sillabe che si inerpicano in montagne inscalabili e che, in un attimo, risolvono la frase in suoni dolci pieni di gentilezza.
Un ragazzo d’origine asiatica che fa jogging a torso nudo. Un gruppetto di ragazze di colore lo indica. Avranno quindici, sedici anni. Ridono ad alta voce. Lui le sente, si volta, le saluta, riprende a correre.
Nei campetti di cemento armato, si gioca una specie di pelota in cui si colpisce la palla con la mano aperta. Ci sono tutte le etnie, così si sente imprecare in modo davvero universale.
«Manhattan è un posto finito», mi aveva detto un amico antropologo in un modo che non ammetteva repliche. Ecco a cosa si riferiva, pensavo. A Brooklyn esiste una complessità che a Manhattan, quartiere devoto al profitto, non c’è più. Manhattan – bellissima, intendiamoci – è però un luogo fatto e finito, che sta segnando la propria sconfitta, con prezzi degli affitti fuori da ogni grazia di Dio. Si è svuotata dei propri abitanti per consegnarsi, anima e mattone, a chi lavora, perdendo l’identità nei propri quartieri. Contano solo i soldi, alla fine. Tutta la vera ricchezza di New York, l’incredibile compresenza di razze e culture, il fatto che tutto il mondo è presente qui e non altrove, ecco: questo potenziale unico non ha spazi di incontro né reti sociali per costruire comunità durature. Per me questo è un vero peccato, indice di una miopia grave. Brooklyn invece ha zone di una bruttezza rara, che fanno davvero schifo. Ma ha dentro di sé anche l’opposto: quartieri gentrificati divenuti gioielli. È un luogo in piena fermentazione. Il cambiamento è la sua qualità percepita più evidente. E poi a Brooklyn c’è Coney Island, in cui davvero la multiformità degli abitanti di New York trova degna rappresentazione di se stessa. Arrusi e uomini in divisa, trans e anziani che danzano merengue, pulle e pescatori, manager con le scarpe di coccodrillo e studenti d’arte che disegnano a mano libera, papponi con pelliccia e catene e russi vestiti di pelle. Siedono al medesimo bar, osservano la medesima ruota panoramica, la montagna russa alle nostre spalle riparte, le urla che si levano tagliano la tela di questa aria di cristallo. Ci sono qui tutti i colori di pelle, tutti gli accenti. C’è l’esistenza con il suo carico di ambizioni e fallimenti, con le disillusioni più dolorose e con la sacrosanta voglia di trascorrere un sabato davanti al mare. C’è il profumo e la puzza della vita, in questo Luna Park. Lou Reed la sapeva lunga quando cantava, con orgoglio e dolcezza, «I’m Coney Island Baby».

La torre arancione sale fiera verso il cielo, sparando musica a volume altissimo. Sta suonando «Easy» del Commodores. Bevo una lager locale, facendo attenzione a non varcare la linea immaginaria segnata da un cartello che ammonisce di non bere al di là di esso. Ecco la profonda ipocrisia che segna l’America. È la terra della libertà, ma guai a bersi una birretta all’aperto. Potrebbero arrestarmi, tipo. Questi controsensi sono continui, a volte esplodono e allora si vede piangere a dirotto qualcuno, contro un muro all’angolo di una strada o nel vagone di una metro. Sono i nervi che si stanno scaricando. La pressione che ti mette addosso questa assurda e meravigliosa New York non l’ho mai provata da nessuna altra parte.
Sul pontile, i pescatori parlano del vento, consigliandosi a vicenda i punti migliori dove lanciare l’esca. Sono asiatici, neri, latini, bianchi. Passa un giapponese con una bicicletta munita di altoparlanti. Ascolta musica nipponica. Avrà più di cinquantanni. Guadagna la fine del pontile, scende dalla bici e si gode l’oceano, canticchiando una strofa della canzone che esce dall’altoparlante.
Vista dal pontile, che si inerpica per un centinaio di metri dentro il mare, la riva è oppressa dai palazzoni che a cento metri da essa si ammassano uno sull’altro. Alti e lunghi, ricordano proprio le costruzioni dell’edilizia sovietica. Scuri e lunghi, sono brutti casermoni che neanche la vicinanza delle giostre riesce a redimere.
Sulla spiaggia, c’è solo una persona. È un anziano che rincorre un sacchetto blu. La schiena curva, le gambe un po’ divaricate dal peso degli anni, l’andamento tremolante. Corre dietro al sacchetto, portato via dal vento, e da come si muove l’anziano pare proprio un bambino. Mi si riempie il cuore di commozione, perché mi ricorda mio nonno. Poco prima di morire, mio nonno era degenerato non nel corpo ma nella mente. Aveva perso la lucidità e attraversava il tempo, proprio come un eternauta: un momento era convinto di avere venti anni, un altro tornava ad avere i suoi ottanta anni, d’un tratto era il piccirìddo di tantissimi anni addietro, con lo stesso stupore negli occhi riguardo le cose del mondo. Nella sua ultima estate, eravamo in una casetta a mare. Uno dei miei fratelli trovò una trottola di legno in un vecchio scatolone. La guardammo come si guarda qualcosa di un’altra epoca, con cura e compassione. Mio nonno la vide e chiese se poteva giocarci. Certo, rispondemmo. Accadde allora qualcosa di incredibile. Mio nonno si levò un laccio dalla scarpa e io e i miei fratelli – e mio padre e mio zio, appena giunti – ci guardammo sorridendo. Chissà che combinerà adesso, pensammo. Eppure il movimento delle dita del nonno era preciso e saldo, come se gli ottantanni non fossero affatto un impedimento. Aveva attorcigliato, secondo una geometria complessa, il laccio della scarpa attorno alla trottola. Si alzò e mentre si avvicinava al muro lo vidi con chiarezza: mio nonno non aveva più ottanta anni ma era come se ne avesse sei, sette, non di più. Era scritto nei suoi occhi. Aveva lo stesso sguardo del piccirìddo prima che cominci il gioco. E così fu. Disse, più a se stesso che a noi: «Due carambole al muro, poi ritorno qui», intendendo esattamente il punto da cui stava per effettuare il lancio. Il suo corpo curvo si piegò, il braccio magro si flettè indietro, poi venne in avanti con velocità e la trottola fu liberata dal laccio. Dopo decenni anche lei tornava a trottolare, finalmente. La parabola fu perfetta, esattamente quella che aveva indicato. Muro, ancora muro, la sua mano conca pronta ad accogliere la trottola. Noi eravamo stupefatti. Mio nonno intanto riannodava il laccio alla trottola. «Cinque carambole e poi gambo del tavolo», aveva sentenziato. Lanciò la trottola e rideva soddisfatto a ogni carambola mentre noi esultavamo come a un golle dell’Italia in finale e lui ci guardava un po’ imbarazzato e io vedevo il bambino che era stato e nessuno di noi aveva potuto conoscere.
Il corpo ha una memoria potente. Non dimentica nulla. Il sapore di un bacio innamorato, il primo schiaffo ricevuto, il gesto per lanciare la trottola.
Il vecchietto da solo sulla spiaggia sta rincorrendo il sacchetto muovendosi come si muoveva mio nonno per recuperare la trottola e io faccio il tifo per lui come lo facevo per il nonno, la sabbia è tantissima, il vento è impetuoso e lui è tanto anziano e precario nei movimenti. Eppure non demorde e continua a correre nonostante rischi di cadere a ogni passo, a ogni buca di sabbia che il suo piede incontra. Finché, finalmente, il vento si smorza e lui allunga la mano e afferra il sacchetto blu. Si ferma, respira e poi sorride prima di compiere il gesto più struggente del mondo: accarezza il sacchetto e, tenendolo per un lembo, lo trasforma in un palloncino, poi saluta il mare, si gira e riprende a camminare verso le giostre, questo altro piccirìddo di ottanta anni con il palloncino conquistato nella mano, l’oceano dietro le spalle e Coney Island davanti al cuore.