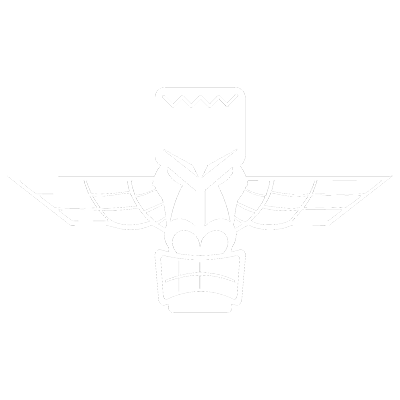Ho scritto su FB un messaggio inequivocabile:
«Ok, sto per andare a fare spinning tipo con Madonna, Alec Baldwin e Taylor Swift. Seguiranno aggiornamenti (EDIT dai commenti: Il NYT mi suggerisce anche «Lena Dunham, Harry Styles of One Direction, Oprah Winfrey». Picciò, Harry Styles of One Direction, mica cazzi e mazzi)».
In metro, ripasso mentalmente le ultime settimane.
Per il compleanno, sapendo che facevo spinning in Italia, degli amici a NY mi hanno regalato una lezione in una di ‘ste super palestre frequentatissime dai vips, così per non sfigurare davanti alle icone del pop e dello showbiz, e per non far fare malafigura ai compagni di spinning del Belpaese, ho pedalato con acribia per tre settimane tre.
Avrei fatto la mia porchissima figura, anzichenò.
Taylor, vìri comu si pedala veloce aggrìtta, giò.
Oprah, ‘un t’a siddiàri, ma talé che c’è cà, sangù.
Madonna, chi ddici?
Alec, pigghiàmone un bello café tutto pagato mio.
Quel mix spontaneo di orgoglio (parecchio) infantile e suverchierìa da emigrato oltreoceano che non vuole fare sfigurare i propri colori patrii, come se la lezione fosse una finale e io l’italiano che si batte per il titolo fuori casa contro tutto e tutti, ecco: questa combinazione di euforia carica di ansia e voglia di prestazione figlia di traumi evidentemente irrisolti mi aveva portato ad allenare la gamba, scalando (solo in parte) i chilazzi in eccesso che l’inverno americano e gli hamburger newyorkesi mi hanno affibbiato senza pietà alcuna.
Con la lezione alle tredici spaccate, giungo in palestra alle dodici e quaranta, consegno alla reception la mia scheda, mi assegnano la bici numero 48 («Uh, come il minuto in cui Pablito segnò il secondo golle al Brasile! Non posso perdere!») e mi dirigo negli spogliatoi.
Sorpresona: sono comunicanti. Nessuna separazione. Mentre mi spoglio, le signore delle pulizie firriàno serene e tranquille nel reparto che teoricamente è quello maschile. In più, compare una ragazza che trotterella verso un armadietto, lo apre, ci butta dentro la felpa, lo chiude e fila di sopra. Io sono ancora con i pantaloni mezzi calati. C’è questa abitudine abbastanza diffusa a NY: chi si reca in palestra non si cambia né si doccia. Giunge già tutto vestito tecnologico, segue la lezione, ritorna a casa e lì, se vuole, si sgràscia. È il prototipo del runner, imperante archetipo del look dello sportivo: uscire di casa, performare, rientrare tra le mura domestiche per lavarsi. Lo spogliatoio diventa così più il luogo dove lasciare giubbotto, chiavi e smartphone che altro. Un appendiabiti, un deposito. Le docce, infatti, sono pochissime rispetto al numero dei partecipanti alla lezione. Sono due, in questa parte maschile, due soltanto.
Altra sorpresa: l’armadietto è ultratecnologico, si chiude con combinazioni numeriche che ignoro. Dopo averlo smurritiàto fallendo ogni tentativo, mi accorgo che sono in ritardissimo. Corro in bagno, mi cambio, consegno il mio zaino a uno dei ragazzi della palestra e proprio alle tredici in punto entro in sala.
E allora ‘sti vips? Ùnne su? Ci sono o no?
Vorrei saperlo pure io, giuro.
Il fatto è che c’è una penombra così intensa che nella sala si vede a malapena. Faccio in tempo a notare che siamo quattro maschi e poi ci sono soltanto donne. Tipo cinquanta. La sala è lunga, le bici sono disposte su tre file. Di fronte, una vetrata a specchio che copre tutta la parete e, su un piano rialzato, il podio dell’istruttrice, con mixer e console.
Mentre regolo manubrio e sellino, entra l’istruttrice, che d’ora in poi chiamerò la Maestra. Indossa un top nero e ha un microfono sulla guancia. Ci saluta dal microfono, «Hi guys», e in sala esplode un boato tipo un gol dell’Italia ai mondiali.
Che sta accadendo?
La Maestra inforca la bike, tocca la console sistemata dietro il sellino e di colpo le fioche luci della sala si spengono. A illuminare l’ambiente, la luce di quattro candele profumate. Praticamente, semu ‘u scuru. «Let’s start», ordina la Maestra e, al buio, tutti iniziano a pedalare furiosamente al ritmo di un pezzo tecnotrance. La Maestra ci invita a chiudere gli occhi, io mi guardo attorno e credo di scorgere come davvero tutte le ragazze (sì, dal mio punto di vista vedo solo ragazze: sono circondato) tengano gli occhi chiusi. La musica incalza, il ritmo si fa più martellante, la Maestra ci istruisce su come espellere il negativo dal nostro corpo: pedalando. Tu pedali e il male esce da te. Non è difficile. Poi, uno scarto improvviso. Cambia la musica, la Maestra urla al microfono incitandoci ad aumentare il ritmo, il volume aumenta, il ritmo esplode, si accendono le luci (tenui tenui, ma sembra il sole ad agosto dopo tutto ‘sto fiocore da candela) e nel momento esatto in cui le palpebre sono toccate dalla luce tutte le ragazze attorno a me cominciano a gridare.
«Oh, yeah».
Ho ufficialmente paura.
Si pedala velocissimo da seduti. Mi allineo al ritmo e cafùddo sui pedali. La Maestra comincia a compiere tantissime flessioni sul manubrio e noi pure, appresso a ìdda. Minchia, è una lezione tostissima, c’è picca ‘i fari. Mi fa male tutto, addominali, polpacci, lombari, timpani. In più, senza orologio alla parete, ignoro quanto tempo sia passato e non riesco a calcolare il consumo di energie. Ho sete, allora bevo e vafanculo se finirò l’acqua a manco metà lezione. Prendo la borraccia, bevo e il disastro si consuma: non vedo letteralmente dove appoggiarla. Non si vede niente laggiù dove dovrebbero esserci le mie caviglie. Dove è il buchino per sistemarla? Pedalo tenendo la borraccia in mano finché la Maestra tocca la console creando una nuova tenuissima luce. Ecco ddùaco il buco, ‘u vìtti, ci cafùddo la borraccia a lampo, gol. Nuove flessioni sul manubrio e tutti in piedi, alè, livello di resistenza dei pedali stretto al massimo. Il sudore gocciola sul parquet e il respiro affannato del gruppo gonfia l’aria, mentre la Maestra pare una silfide che danza sui pedali. Ci comanda di aumentare il ritmo e io e le due ragazze ai miei fianchi le obbediamo. Ripiombiamo nello scuro ma l’occhio si è abituato a questo presente di tenebre così riesco a intravedere la ragazza alla mia destra che stringe i denti e si arcua in avanti con l’incalzare del ritmo. La Maestra riprende a urlare al microfono. Il livello di sforzo è davvero importante, siamo tutti in piedi a jittàre sangue sui pedali. La ragazza alla mia destra è contratta in una smorfia sofferente, quella alla mia sinistra ha il capo chino e suda, la luce ballerina della candela la rende la scena drammatica, la Maestra grida al microfono che noi siamo un esercito, «Push, push, puuuuuush!», e la tensione cresce e la fatica esplode, dobbiamo spingere più forte, «C’mon», ancora, ancora, il cuore sale in gola, «Faster!», i bassi amplificati risuonano più potenti, «Ten second more», il ritmo aumenta ancora, il volume sale, «Seven, six», le gambe sono infuocate, la ragazza alla mia destra digrigna i denti e stritola il manubrio, «Three, two», la musica esplode in fuoco d’artificio di ritmi che ricordano i flipper della mia infanzia, la luce si accende, la salita è finita e tutti quanti in sala –TUTTI– urlano come Marco Tardelli nella finale del 1982 mentre la ragazza accanto a me molla la presa dal manubrio e strilla con tutte le forze che ha ancora in corpo «This is the best day of my life! Fuck my ex».
Parte un autoapplauso che il gruppo si autodedica, acutissime si sollevano le urla e l’enorme specchio davanti a noi ci restituisce l’immagine sudata della nostra impresa testé compiuta.
È l’America che celebra se stessa. È il trionfo della performatività in ogni aspetto del quotidiano, nel lavoro come nei talk, nello sport come nel tempo libero. La sessione d’allenamento è una celebrazione dell’eterna lotta contro l’Impero del Male, la bike è la spada laser e noi pedalatori siamo gli Jedi che si rompono il culo per ottenere, alla fine, la vittoria del bene, o un bell’applauso davanti allo specchio condito da urletti da stadio, che tanto poi è lo stesso. La distinzione tra vita e teatro è abbattuta. Non esiste il palcoscenico perché è tutto una performance, così la tensione è assoluta in ogni gesto, in ogni parola. Oggi non è un giorno come un altro. Oggi non è neanche un giorno migliore degli ultimi trascorsi. Oggi è – deve essere – il giorno più bello della vita, senza se o senza ma. Un giorno straordinario, super, indimenticabile. E questo si ripete sempre, quotidianamente. Una corsa sfrenata verso l’irripetibilità del tutto. Qui si canta l’unicità dell’azione, in cui si rappresenta se stessi come performer in ogni attività eseguita.
Gli applausi si smorzano, le grida diminuiscono, la luce digrada, ancora buio, si ricomincia. La nuova sfida è stata lanciata. Il brano pompa i bassi, la Maestra lancia suggestioni al microfono e noi ne ripetiamo le movenze come se l’intera nostra esistenza dipendesse dalla precisione delle mosse: flettersi in avanti, controllare gli addominali, spingere sulle gambe, mantenere il ritmo. Io, intanto, ho completamente perduto il senso del tempo che scorre. Forse sono capitato in una lezione infinita, di quelle del genere «ne resterà uno solo», che terminerà soltanto quando saranno morti tutti, tranne uno. Mi impegno allo spasimo e devo ammettere che le ragazze attorno a me pedalano benissimo. All’improvviso, un colpo di scena. Ualà, la Maestra addùma la luce e scopro con terrore che tutti tengono dei pesi nella mano destra. Tutti: la ragazza a destra e quella a sinistra, le ragazze davanti e la Maestra, gli altri tre maschi e le figure riflesse nello specchio. Tutti quanti hanno i pesi. Tranne me.
La Maestra mostra il lavoro muscolare da eseguire con i pesi e il gruppo lo esegue. Tutti stanno lavorando con i pesi. Tutti. Tranne me.
È così che succede?
È questa vergogna infinita il preludio alla morte?
L’ansia mi divora ed è amplificata dagli svariati «Fuck» di fatica che la ragazza alla mia destra strepita con il viso deformato dalla fatica. Nello specchio sono l’unico che non si muove con gli altri. Sono la nota stonata, quello che sbaglia la coreografia, la linea che trema nel quadro. Io sono il parassita.
Non ho salvezza né redenzione.
O agisco o muoio.
È un attimo.
Mi calo, prendo la borraccia e come se fosse la cosa più naturale del mondo, sfoderando la mia faccia di bronzo migliore, la comincio a usare come un peso.
E su. E giù. Di lato e poi ancora su.
Adesso nello specchio la coreografia è perfetta. Le mani si sollevano all’unisono e portano in alto un peso nero tranne lì, in quel punto in cui si impone quel punto blu marino. È la mia borraccia. Ne vado fierissimo. Sale e scende segnando il ritmo del nostro movimento, con l’acqua che sciaborda da un estremo all’altro, rimandando quel suono di gorgoglio che istantaneamente provoca un immediato quanto assoluto bisogno di fare la pipì. Nel gruppo ricominciano i gridolini ma la mia borraccia non demorde e alta e fiera si staglia nella sala ed è chiaro ormai che anche noi due adesso facciamo parte della grande famiglia dello spinning dei vips.
La lezione finisce così. Stretching, spogliatoio, doccia (siamo in due, un significativo 50% dell’intero gruppo maschile), mi asciugo i capelli, esco. Union Square è sempre lei, persone che sfrecciano veloci scansando macchine e turisti. Ho fame, vado al messicano, ordino riso con carne, fagioli, guacamole e jalapeño.