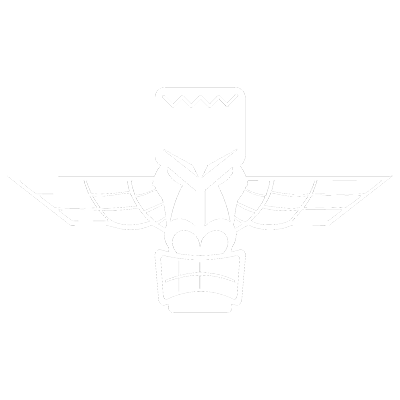I filosofi, nonostante siano visti con sospetto, in quest’epoca di tutto-e-subito e di affermazioni poco ponderate, l’hanno sempre saputa lunga. Coloro che li additano come personaggi strambi col brutto vizio di parlare in modo incomprensibile, sempre a ciarlare di metafisica, di trascendente e d’iperuranio, commettono infatti un grave errore. È noto che fin dai primordi, in quella terra ricca di pecore e grano (e di tutti i loro incroci possibili) che era l’antica Grecia, la filosofia abbia messo in chiaro un presupposto fondante piuttosto pragmatico: per filosofare tocca essere vivi.
Questo principio, suffragato dall’evidenza empirica che i filosofi, una volta deceduti, hanno la peculiare tendenza a non filosofare più, attraversò silenziosamente secoli e secoli di pensiero logico-deduttivo, nascosto nella massima popolare, tuttora in voga, “A pancia vuota non si ragiona”. Alla fine, verso la seconda metà dell’800, pur di smaltire l’overdose di idealismo della casta di Hegel e compagnia, un po’ di sano materialismo irruppe nuovamente sulla scena, e alcuni filosofi ribadirono che: va bene lo spirito, ma noi si ha fame.
Chi espresse senza mezzi termini questa verità alimentare fu il tedesco Ludwig Feuerbach, comunista senza saperlo, ma ateo consapevole, che nel 1862 scrisse un’opera che già nel titolo conteneva la massima della sua filosofia, ovvero: “L’uomo è ciò che mangia” (sfortunatamente il titolo completo del libro era “Il mistero del sacrificio o l’uomo è ciò che mangia”, e nessuno arrivava a leggere la seconda parte, credendo così di avere in mano un thriller sanguinolento).
Ora, massacrando impunemente (essendo Feuerbach deceduto, non solo non può filosofare più, ma non può nemmeno fracassarmi di botte) il vero pensiero che giace dietro la sua massima, cercherò di trasferire la sua filosofia all’epoca attuale, traendone colorite conclusioni.
A meno di non essere una specie di Mahatma Gandhi della cucina, tutti noi siamo, volenti o nolenti, consumatori finali dei prodotti dell’industria alimentare. In pratica, quello che mangiamo esce da una fabbrica. Non c’è niente di assurdo: in certe fabbriche fanno le auto, in altre gli iPad, e in alcune fanno il cibo. Come capita per quella automobilistica, anche l’industria alimentare cerca di venire incontro ai gusti e alle esigenze delle persone. Un’utilitaria che consuma poco non è molto lontana da una pasta corta che cuoce in 6 minuti. Cos’è la Smart se non un primo precotto monoporzione? Tolte le sfumature, ciò che importa è accontentare il cliente.
Ora, quando si va a comprare un’auto, qual è il dettaglio che più c’interessa? Sì, è vero, diamo un’occhiata alle prestazioni, ai consumi, alle varie apparecchiature di bordo. Però, siamo seri, niente c’interessa più di ciò che appare all’esterno: la linea, ovviamente, e, più di tutto il resto, il colore. Ecco, per il cibo è la stessa cosa. Un gelato alla fragola blu è inaccettabile, così come una merendina verde, o dei biscotti viola. Le mozzarelle blu, al limite, ci possono anche stare.
Così, per fare di noi dei consumatori felici, l’industria alimentare, oltre a soddisfare anche gli altri aspetti sensoriali (una crema spalmabile che sa di cozze non andrebbe mica bene, anche se della giusta tonalità), è lieta di fornirci anche il colore appropriato. È per questo che esistono i coloranti alimentari, ovvero quella categoria di sostanze, alcune naturali, altre meno, altre ancora proprio per niente, che nelle etichette figurano con quelle misteriose sigle tipo E107 (giallo 2G), E131 (blu patentato V) o E171 (diossido di titanio). Tutte le E che vanno da 100 a 199 compongono la tavolozza con cui si colorano i cibi. L’aspetto cromatico, inutile negarlo, è fondamentale. La merda, se non fosse E155, probabilmente la mangeremmo.
Perciò, accompagnati ai cibi di cui l’industria alimentare ci rifornisce senza tregua, ingurgitiamo anche un arcobaleno di sostanze il cui unico scopo è farci sentire a nostro agio mentre li portiamo alla bocca, per appagare il nostro bisogno estetico, perché va bene mangiare, ma anche lo spirito vuole la sua parte. La conclusione a cui si giunge inequivocabilmente è che, se l’uomo è ciò che mangia, al giorno d’oggi siamo tutti degli Uniposca.
Povero Feuerbach.