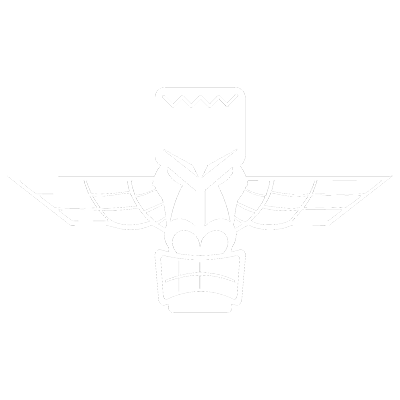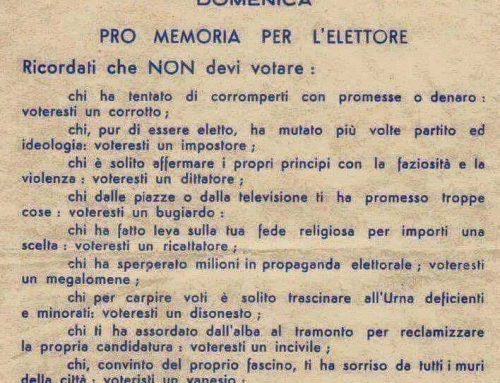– «Fammi mezza porzione aglio e olio e peperoncino.»
– «E per secondo?»
– «Appena finisco t’u dico.»
Mi piace la pasta aglio e olio e peperoncino. È netta. I sapori hanno una riconoscibilità tale che la difficoltà di preparazione sta nell’equilibrio dell’insieme. Il giallo dell’olio intriso di aglio, ché senza il piatto sarebbe triste, un luglio senza sole. Il rosso del peperoncino che gioca a nascondersi mentre il verde del prezzemolo compare dappertutto. E poi: il bianco del caciocavallo, che dà risalto e profondità al volume del gusto, il caciocavallo che dall’alto scende sul piatto come la mano del padre sulla testa del figlio ma piaaano ca ‘u piccirìddu s’addurmiscìu ora ora, shhhh!, asennò s’arruspìgghia, mentre la sua mano di padre non è mai stata tanto gentile e tranquilla come ora che accarezza la testa del figlio piccirìddu, sogni d’oro gioia mia, dormi con gli angeluzzi, ciao.
– «Te ccà ‘a pasta.»
– «Portami il caciocavallo, Ciccio, per cortesia.»
– «E te ccà puru ‘u cascavàllu.»
Mano sinistra sul cucchiaio, caciocavallo a tempesta sul piatto, forchetta a firriàre tra gli spaghetti, bocca chiusa a masticare, birra Forst agghiacciàta nel bicchiere, minchia che bella la vita a volte.
Due scippi in mattinata nel centro storico, uno in serata a Mondello. Il telegiornale. Ci hàv’a essere ‘a televisione addumàta nell’altra stanza. Eccheccazzo, non si può mangiare con la televisione addumàta. Ci sono piaceri, e il mangiare è tra questi, che sono muti e hànn’a essere goduti in silenzio. Estorsione e richiesta di pizzo, continua la televisione, ma a me ora di sentire te, televisione insensibile, a mmìa ‘un me ne può fottere di meno, non ce la puoi fare a sconzàrmi il prìo della pasta aglio e olio e peperoncino cucinata a mestiere, non ora, no, adesso il pomeriggio fuori dalla taverna è placido, un sospiro prima del sonno, e niente e nessuno può rovinarmi ‘sta giornata di tedio sospeso e innocuo.
– «Ciccio, spegni sùbbito d’a buttana d’a televisione, sì, fastidio mi dà, spegnila amunì, oooh, deogràzzias!»
Pace, silenzio, ancora un etto abbondante di pasta e birra Forst agghiacciàta nel bicchiere, e che ci vuole, in fondo, per avere un momento di gioia in questo straccio sporco di vita?
Il momento è tanto solenne che potrebbe essere una metafora di… di… di qualche cosa insomma, ma davanti all’ultimo boccone: metafore, elegie, simboli si nni pònno ìre bellamente a fare ‘nto culu. Il mangiare è poesia già di suo, e non serve altro.
Il mangiare s’abbàsta.
Mangio con una lentezza sontuosa e necessaria.
Tutto diventa una processione, e che Dio benedica chi inventò la pasta aglio olio e peperoncino, amen.
La forchetta che mi balla tra le dita mi regala un sorriso. Quando sbatte sul piatto crea un ritmo domenicale e tutto diventa fiera e giostre.
– «Ciccio, per secondo un bollito coi giri e portami un’altra Forst bella agghiacciàta.»
La birra Forst. Mi piace la Forst. Assai mi piace. Mi ricorda i piedi di mio zio Alfredo. Era muratore mio zio Alfredo. Giacca marrò e una MS morbida addumàta tra le labbra. Mani sporche di calce, schizzi di cemento tra le rughe delle guance. Le gambe corte e tozze. Un asso di bastoni tatuato sul dorso del piede destro con scritto: «vacci liscio». Ai suoi piedi, sempre, una bottiglia di Forst. Sempre là. Sempre Forst. Sempre agghiacciàta.
– «È bella la birra», mi dicevi, zio Alfredo.
– «‘Un è che posso travagghiàre senza avere bellezza da bere», e giù un’altra Forst. Poi appena la finivi, per magia, «Ma come fai, zio?», eccola là: un’altra Forst ai tuoi piedi, tutta nuova e tutta bella agghiacciàta.
– «Ma come faiiii?», ti chiedevo io, zio Alfredo, e tu ridevi, mi prendevi in braccio e io mettevo le mie mani tra i tuoi capelli bianchi di neve. Che stronzo sei stato, zio: non me l’hai mai spiegato come facevi a fare apparire la birra Forst sempre piena, bella agghiacciàta, ai tuoi piedi. Un bellissimo trucco era. Davvero. Bellissimo. Mi avrebbe fatto molto comodo. Me lo sarei giocato con le femmine. Mi avrebbe aiutato sicuro nell’abbordàggio.
– «A và, zio, dimmìllo: come fai?», ma tu: niente, ridevi e io che tiravo i tuoi capelli di neve.
Quando poi ci fu la comunione di tuo figlio Vito, mio cugino, io scoprii che tu, zio Alfredo, tu non avevi i capelli bianchi ma neri. Nerissimi. Il nero più profondo e definitivo. Una rivelazione fu, come scoprire i primi peli sul mio pube. Tu, zio Alfredo, avevi i capelli neri che più neri solo l’abito da lutto della nonna. Gesù, ma se la calce ti rendeva i tuoi nerissimi capelli tutti quanti bianchi bianchissimi di neve, ma cosa dovevi averci dentro i polmoni, zio? E infatti, all’età di quarantatré anni, te lo ricordi zio Alfredo?, tu muori per una forma di pneumoconiosi, che sarebbe l’accumulo di polveri nei polmoni, lasciando da questa parte del lutto: i quindici anni di tuo figlio Vito, le spalle di Grazia tua moglie, il nero dei tuoi capelli di corvo, un muretto alzato a metà accanto a un campo di calcetto, un pallone di cuoio gonfio sempre lucidato, tenuto sopra il tuo comò, e sette birre Forst nel frigo di casa tua, tutte cose che parevano una preghiera alle bellezze della vita e allora riposa in pace zio et nunc et semper et in secula seculorum amen. Alla tua, zio Alfredo, ‘sta Forst bella agghiacciàta è per te, il rutto poderoso che ne consegue per quei sucaminchia che ci vogliono male.
Tracanno il bicchiere tutto d’un fiato, rutto e sono quasi felice adesso che le quindici si avvicinano e il silenzio di questa quasi fine di novembre non fa male.
Il bollito arriva con un profumo che merita rispetto prima ancora che studio. I giri bolliti sono i suoi compagni ideali: verdure umili e tranquille, non invadono e sanno aspettare.
Ottimi i giri: conoscono il valore del tempo e sanno la dote dell’attesa.
Antìcchia di pepe ‘ncapo, olio in pietra ed eccomi, bollito: fammi tuo, con dolcezza e in profondità. Morbido ma di sostanza. La carne è buona quando i denti ci affondano e fiorisce in bocca tutto il piacere del morso. Come nel sesso. Mordere è un’arte, serissima. A metà del lavoro osservo i filacci di carne del bollito sfaldarsi piano, fiore di carne che spampina, che noi carne siamo, ed è davvero così poco ciò che ci tiene insieme: un sogno, la disperazione, l’amore o i loro contrari. Ma tanto, poi, è sempre lo stesso campo di battaglia.
Mentre mi sciacquo la bocca coi giri, entra nella taverna un cristiano, enorme. A occhio, quasi un metro e mezzo di spalle per un metro e novantacinque di muscoli. Giacca di pelle con una toppa blu sul braccio destro, un mazzo di chiavi nella mano sinistra. Adesso siamo in tre: io, Ciccio e lui. E lui, dall’alto del suo metro e novantacinque di muscoli, si piazza davanti a me e, nella solitudine vasta ed estesa della taverna vuota, tra tutti i posti disponibili, lui, di giacca di pelle vestito, «C’è permesso?» mi chiede, indicando proprio la sedia dirimpetto alla mia.
Sarà stato il silenzio della mia bocca che masticava i giri, sarà stato il vuoto del posto dirimpetto al mio, sarà stato che placido e sereno è questo pomeriggio, sarà stato il suo metro e novantacinque di muscoli. Tutto afferma un sì inequivocabile.
– «Certo che c’è permesso, s’accomodàsse.»
Da seduto, appare ancora più grosso. I muscoli del corpo sono fermi, come abituati all’assenza di movimento. Ma gli occhi. I suoi occhi sono troppo agili, troppo veloci, troppo in fuga in ogni direzione, troppo in contraddizione con la stasi della sua mole. Poi, i suoi occhi scorrono il menù del giorno scritto a penna blu su un foglio a righe bianco. Semplicemente alzando un dito riesce a chiamare Ciccio. ‘Sto cristiano è qualcuno che conosce le regole del comando.
Poi i miei occhi verdi ascoltano stupefatti e a bocca aperta una ordinazione leggendaria. La sua.
– «Portami una bolognese, una alla grassa, una con le zucchine fritte e una aglio e oglio, per secondo una fetta di carne di cavallo, uno spiedino, un bollito, antìcch’i spezzatino e una frittura di calamari. I primi, scegli tu in che ordine, uno alla volta. I secondi, pùru.»
– «Gradisce contorno?»
– «I giri ci sono?»
– «Sì.»
– «Patate fritte ci sono?»
– «Sì.»
– «Insalata di pomodoro?»
– «Sì.»
– «Tutt’e tre.»
– «Da bere?»
– «Vino e azzùsa.»
– «Quanto?»
– «Un litro per volta.»
– «Pane?»
– «‘Nca cìerto, ha rimanere digiuno?»
Non ci fosse stato il dubbio che poteva parère una pigghiàta p’u culu, e se lui non fosse stato tanto alto e massiccio, giuro: mi sarei alzato in piedi e avrei applaudito commosso per questa ordinazione fotonica. Stavo per assistere a un capolavoro. Sì. Un capolavoro. Ma, come troppo spesso dimentico, la realtà non è mai ciò che appare.
Lui mangia e io non ce la faccio a staccare il mio sguardo da lui.
È al secondo piatto, pasta con le zucchine fritte, e sta mangiando non come se avesse una fame atavica da stroncare.
No.
Non mangia come se fosse a digiuno da sette vite.
Non sta mangiando per l’atto del mangiare in sé.
Il suo è un mangiare di disperazione.
Il suo è un mangiare contro.
Io lo fisso e non ci posso fare niente, lo so che è brutto fissare qualcuno che non conosci mentre sta mangiando, a me darebbe un fastidio insopportabile, ma non ci posso davvero fare niente: i miei occhi sono incastrati su di lui.
I suoi occhi invece non stanno fermi. Non ci riescono. Rimbalzano dal piatto con la pasta a zucchine fritte ai miei occhi al muro alla forchetta al poster del Palermo ai miei occhi al santino di padre Pio al pane alla mattonella all’ingresso con scritto Venezia alle sue due mani adesso sul tavolo per posarsi infine, definitivamente, dentro i miei due occhi, verdi e fermi davanti a lui.
Non è buio, non passano motorini, non tira vento.
E, con lo stesso stupore con cui cade la prima goccia di pioggia, accade.
E lui, mani ora davanti al viso.
Spalle curve in avanti verso di me.
Occhi fermi dentro i miei.
Lui comincia a piangere.
– «Sono uscito oggi», mi dice.
– «All’una», aggiunge.
– «Nna strada, fùora, ‘un c’era nùddu, vabbè, hànn’a essere tutti quanti a casa», mi dice.
– «‘U tempo d’a strada, manco menzòra e arrivo a me casa, tuppulìo e aprono», mi dice.
– «La tavola era tutta apparàta, tutt’u manciàre sopr’a tovàgghia, e tutta la mia famiglia, me mogghière, i suoi fràti, me sorella Ina: tutti ca stavano manciàndo», mi dice.
– «Si scordarono che uscivo oggi», mi dice.
– «‘U capisci: a ‘me famìgghia si scordò ca, dopo cincu anni, io era oggi ca niscìeva.»
Poi, non dice più niente e torna a guardare il piatto di pasta.
Occhi come unghia, i suoi.
Ma il naufragio è ormai iniziato e lui non ci può ma per davvero fare niente.
Poi si asciuga gli occhi, riprende la forchetta e finisce in silenzio la pasta a zucchine fritte.
Lo lascio con una pasta aglio e olio sul tavolo, il litro di vino e azzùsa che sta per finire, il pane ora spezzato dalle sue mani.
– «Quanto pago, Ciccio? Te ccà, senti: portaci una Forst pagata mia al tavolo, ma bella agghiacciàta però, mi raccumànnu, ciao Ciccio, nni virìamu, ciao.»
Esco dalla taverna, fuori è Palermo e non piove, mentre tre nuvole stanno tranquille su un mare benedetto e nel motorino che sta passando due ragazzini cantano una bella canzone di sentimento.
[artwork by aMusoDuro]