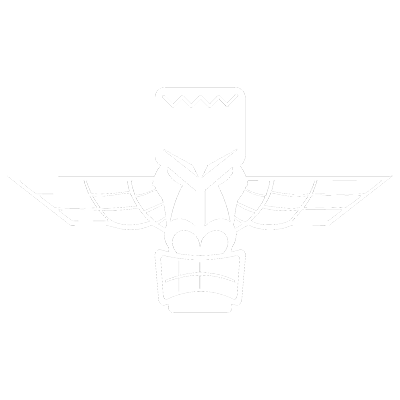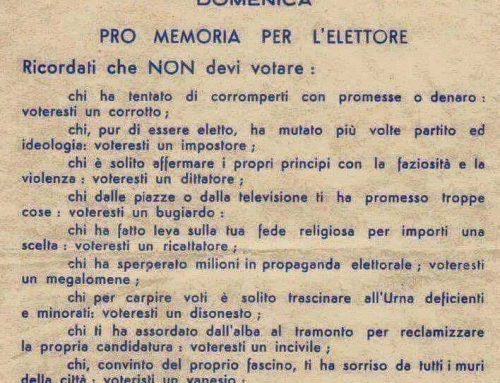Capii che le cose stavano prendendo una brutta piega quando, in seconda media, all’interrogazione di musica “suona un brano a piacere col flauto” eseguii l’intro di Curami, dei CCCP. Con tanto di armonici e schiaffi in faccia ai compagni nelle prime file.
Le cose alle superiori non migliorarono. Anzi. Sarà che pure lì, per qualche ragione ancora a me poco chiara, anziché iscrivermi come tutti al liceo, a ragioneria, che so, all’Istituto Alberghiero, optai per le Magistrali. Dico, 469 studenti, di cui solo 18 maschi. Quattro nella mia classe: un ripetente e due ritardati. Io ero il quarto. E tutte quelle ragazze che non riuscivo neanche a guardare in faccia, figuriamoci a chiedere loro di uscire. Mi sentivo come quel punto anomalo che esce fuori dalla retta lineare e ti fa dire “porco cazzo, se non c’eri tu sarebbe stato perfetto.” E invece. Eccomi qua.
L’ora di educazione fisica, per esempio, noi maschietti eravamo costretti a farla separata dalle femmine. Di pomeriggio. Così mi ricordo che l’unica era farsi delle gran partite a calcetto, nella palestra della scuola. Come porte usavamo i materassoni blu, quelli duri, poggiati di fianco. L’insegnante, i primi due anni, era un tizio credo abruzzese che sparava dei bestemmioni grandi come case perché ogni tanto ci facevamo prendere la mano dal testosterone e tiravamo certe pallonate contro la vetrata della palestra, metafora di non so bene cosa.
Con il tempo la situazione migliorò, nel senso che mi abituai a quella condizione di emarginazione dorata, di minoranza privilegiata, ché in paragone ad altri amici miei del Tecnico, 800 uomini per 10 ragazze, non me la passavo poi così male. L’unico rischio era di passare per frocio, che ai miei tempi era solamente un insulto, dato che nessuno ne aveva mai visto uno da vicino, tranne Renato Zero in TV, che però non aveva mai detto chiaramente di amare il suo stesso sesso. E poi ai suoi concerti ci si andava perché era pieno di figa. Ma anche lì, a 17 anni qualsiasi cosa con più donne che uomini era una situazione definibile “piena di figa.”
Il contatto prolungato con il mondo femminile m’insegnò un sacco di cose. Prima di tutto che anche le ragazze guardavano il culo dei maschi. E se potevano te lo tastavano, arrossendo come fanno le donne: con la lingua in mezzo ai denti e un mezzo sorriso che a noi maschietti provocava tsunami ormonali impossibili da controllare.
Imparai anche ad ascoltare i discorsi delle mie compagne di classe. No, niente di speciale, bastava stare zitti e lasciarle parlare. Quando finii quel primo percorso di vita ovattata, mi ritrovai all’università. All’inizio avrei voluto studiare filosofia, ma tutti quanti si mettevano a ridere, perché “non ci si mangia con la filosofia”. Lettere non m’interessava, per non parlare di tutte quelle materie da giacca e cravatta come Medicina, Giurisprudenza, Economia e Commercio. Per carità. Io volevo studiare qualcosa che al solo pronunciarne il nome la gente sarebbe rimasta senza parole. Così optai per Chimica, ma fu un attimo, perché quando caddi nel programma del corso di studi di Biologia sentii una rivoluzione dentro di me.
Che cosa meravigliosa poteva essere quella facoltà? C’erano tutta una serie di materie a metà tra un corso del 1600 e un film di fantascienza. Da Zoologia a Biologia Molecolare, da Ingegneria Genetica ad Astrobotanica e il mio preferito: “Dalla Genetica ai datteri mendeliani”. Così, per anni, studiai come classificare i viventi e poi come farne dei cloni.
E anche lì, più donne che uomini, ma soprattutto più fuori sede che studenti della mia città. Questo fu il “nuovo mondo” a cui mi avvicinai per puro caso, prima di esserne risucchiato del tutto, al punto che i primi anni li vissi come uno di loro. I viaggi in macchina a ritirare il pacco mandato dai genitori, un pacco pieno di cibo e speranza che ci trasformava in bambini di 10 anni davanti l’albero di Natale. Le feste gratis del giovedì sera, i centri sociali, le cene a casa, le ore passate nell’aula grande di Chimica, dove facevamo gli esercizi alle lavagne grandi, fumando.
A 24 anni, poi, decisi di andarmene di casa e presi un appartamento con il mio amico A, gay. In due anni di convivenza, a Centocelle, in una casa con un terrazzo bellissimo vista periferia (e un gatto roscio), conobbi tutta la comunità gay di Roma. I primi Mucca Assassina, al Castello, l’Alibi, Radio Londra, il Gay pride del 2000 furono, senza saperlo, il prodromo alla mia eterosessualità. Perché se di una cosa divenni sicuro, in quel periodo, era che l’universo femminile continuava ad intrigarmi molto di più, anche perché sentivo di conoscerlo molto meglio di quello maschile.
Infine, stufo della mia città, emigrai all’Estero.
Fuori dall’Italia conobbi il Mondo, quello vero degli scoppiati, i musicisti, gli emarginati, i Sudaca, gli spagnoli, “I mostri” e mi diedi alla musica, all’alcol, ai rave, ai concerti e alla cocaina. Serate chiusi in casa con il piattino riscaldato, la musica e i video della Roma di Spalletti su youtube, fino a quando decidevamo di uscire.
Così gli inverni passavano come una lunga e infinita notte, tra locali notturni, musica e laboratorio. Ogni tanto m’innamoravo pure, e quando lo raccontavo gli altri ridevano e mi presentavano sempre qualcuna. In verità non ho mai fatto troppa selezione su chi portarmi a letto. Mi bastava sapere che ci saremmo divertiti. E così era, anche quando non andava per il verso giusto, ma poi quale dovesse essere questo verso, non l’ho mai capito.
Ad oggi continuo a fare quello di sempre: cercare nuovi mondi a me sconosciuti. Il divorzio, il matrimonio, i figli, la musica, altri nuovi mondi, la ricerca. Ogni tanto divento nostalgico dei miei 30 anni, ma solo perché me li ricordo bene, troppo bene. E questo è un problema, dato che si perde un sacco di tempo a ripercorrere scene già vissute, anche se mille volte.
Sono stato felice a tempo pieno. Ora lo sono a tratti, perché si diventa grandi e l’assolutismo delle emozioni lascia il posto alla conoscenza del vissuto.
Una cosa però ho capito: che non c’è nulla da capire. E anche che non ho mai detto no a un progetto.
[artwork by aMusoDuro]