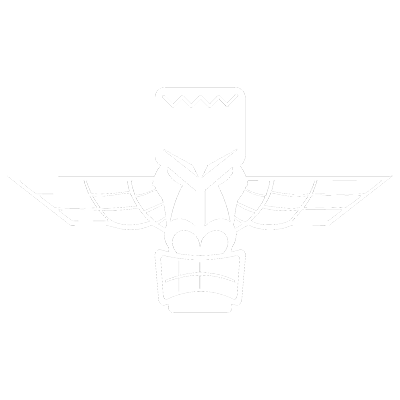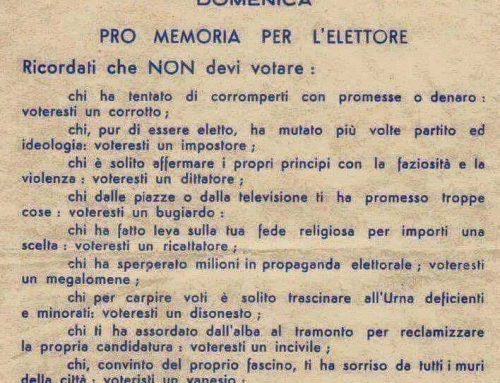Bonghi. A 18 anni decisi di imparare a suonare i bonghi. Nulla di strano, fa parte del normale processo formativo di un qualsiasi ragazzo milanese, cattolico, di buona famiglia, amante della natura e dell’aria aperta con una ristretta cerchia di amici fumati fino al duodeno.
La prima cosa da fare era procurarmi i bonghi. La fiera di Senigallia è da sempre il luogo deputato per l’acquisto di “Beni di cui poi ci si pente di averli comprati”. Il venditore di bonghi e altra utensileria da storditi è un pugliese cicciotto con i dread biondi a coronare la piazza pelata che ricorda vagamente Frengo. “Sono originali africani – mi assicura – vengono dal Congo”. Mentre con fare esperto accarezzo la pelle rugosa di un jambè, accorgendomi in seguito che era la testa di un bimbo sudamericano macrocefalo, lui raddoppia: “Li vado a prendere io personalmente tutti i venerdì, parto al mattino, torno la sera e il sabato li vendo, sono bonghi freschissimi!”. Obietto che il Congo non è proprio un viaggio da poter fare in giornata, ma lui spiega: “C’è il fuso orario”.
Insisto, il Congo si trova a sud, molto a sud e il fuso orario è di al massimo un paio d’ore, avanti o indietro, ora non so, ma non tale da poter giustificare un viaggio andata e ritorno in giornata Linate/Brazzaville. Il rastafari leccese si altera: “Cazzo sei, uno sbirro? Un giornalista? Tu fai troppe domande per voler solo comprare dei bonghi. Io faccio un lavoro onesto, se non li vuoi comprare vai a farti un giro”.
Tiro fuori le 20mila lire e me ne torno a casa felice. So che avrei dovuto cercare un insegnante di bonghi, ma gli unici due che conoscevo erano gli inseparabili gemelli Guzzoni, di Baggio. Il problema era che uno stava dentro a San Vittore per spaccio e l’altro lo aspettava fuori sulle panchine di Piazzale Aquileia da sei mesi e non aveva la minima intenzione di muoversi da lì. Insieme, uno fuori e l’altro dentro, facevano dei duetti di percussioni che si sentivano da Piazzale Baracca fino a Sant’Ambrogio. Il problema era che se quei due non si fumavano almeno tre canne di Libano rosso suonavano da schifo e, mentre quello fuori era sempre strafatto e teneva tutti i ritmi, il gemello in carcere, non potendo fumare, andava talmente fuori tempo da aver spinto al suicidio 3 ricettatori senegalesi, due falsari di Rozzano e un albanese arrestato per furto che sarebbe uscito da lì a poche settimane. Il direttore del carcere pensava addirittura di prolungargli la pena per risolvere il problema del sovraffollamento.
Io, però, dovevo imparare a suonare, altrimenti come avrei passato il tempo, mentre tutti i miei amici limonavano sul prato del parco di Trenno? Decisi così di provare da solo accompagnando tutte le canzoni del repertorio classico dello sconvoltone professionista, da Jackson Browne a Bob Dylan. Mi chiusi in cameretta armato di stereo, bonghi, 28 cassette da 120 e tre etti di Afgano nero, dalle 18 di sabato alle 22 di domenica. In sequenza riuscii a: far piangere la donna di No woman no cry di Bob Marley, sterilizzare il gatto di casa, murare viva una coppietta che si faceva un giro nel Tunnel of Love dei Dire Straits, far chiudere l’Hotel California degli Eagles, Roxanne dei Police ha smesso di prostituirsi per cominciare a farsi pesantemente, far tornare in bianco e nero il televisore a colori nuovo, invecchiare di 14 anni Nicoletta Orsomando mandandola in pensione anticipata e far bestemmiare mia madre per ben 10 minuti consecutivi rendendo vana l’ora e mezza di novena e rosario da cui era appena tornata. La quale madre, credendomi posseduto, sfondò la porta brandendo un rarissimo crocifisso preso a Loreto nell‘82 per la vittoria dell’Italia ai mondiali di Spagna con il Cristo in croce che urla alla Tardelli.
Optò, più razionalmente, per una visita dal dottore di famiglia il giorno seguente.
Il dottore, un vecchio mattacchione, appena mi vide capì subito e ridendo disse a mia madre: “È una malattia molto rara, si tratta di “Ritmo nel sangue”.
Meno male, pensai, per un attimo ho avuto paura si trattasse di una Duna.