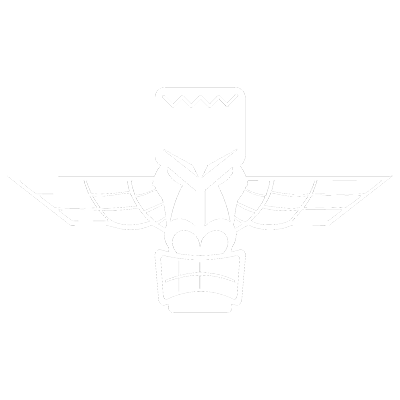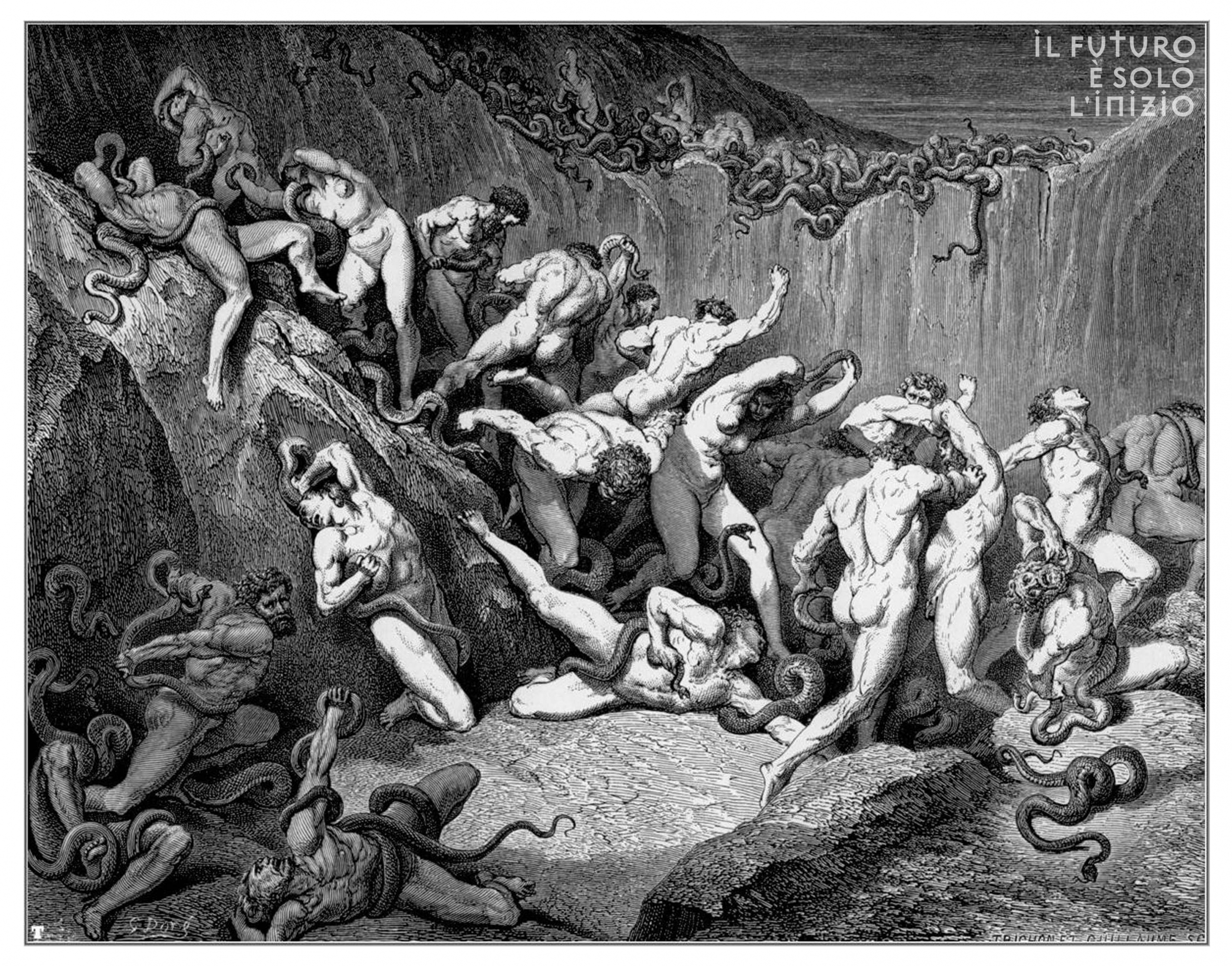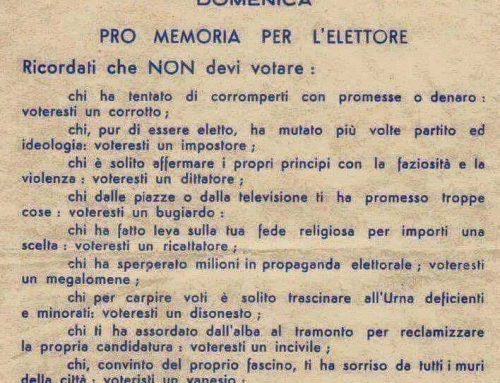A gran distanza dal patìr dei rei
ch’ivi s’attorce rimbombando sordo
tra i gravi e eterni vincoli ipogei
s’ergeva cupo un loco che ricordo
su sé racchiuso e cinto in guisa stagna,
di brama intriso e d’ingordigia lordo.
Schierati al suol dell’empia conca magna
s’aprivan vacui centoquattro deschi
e in circo ad essi, al par di magra cagna,
sostavan spettri ad eloquir grotteschi,
de’e quali nulli udivan l’altrui detti
pur ciondolando in aere i propri teschi.
Sicché mi volsi e chiesi: “Tali abietti
chi son, Maestro, e cosa li accomuna?”.
Rispuosemi: “Son questi i maledetti
che dall’altrui soffrir cavar fortuna
spandendo speme infetta e manigolda
non supportata da sostanza alcuna
e al par di squali attratti sulla tolda
son condannati adesso a divorare
la propria e sola carne alla Leopolda.
Lì vedi Serra, il primo a finanziare
le attività funeste della loggia
torchiando chi potèa di più non dare.
Accanto a lui la Boschi che si sfoggia
per rafforzar l’idea che pulchra imago
dà valor maggio al posto che s’alloggia,
e la Pinotti in ruolo di virago,
Poletti, poi, perito in pallamano,
e potrei dirne ancor, ma non divago”.
“E quello in alto”, chiesi, “che da insano
barcolla goffo, muto, e assai maldestro
dall’orlo del suo scranno, il più lontano?”.
Al dimandare mio lo mio maestro
chinò lo capo e prese a mormorare:
“Colui che vedi triste e privo d’estro
non m’è permesso di poter nomare
poiché lo contrappasso ch’egli sconta
è lo diniego a più comunicare,
obliato dai ricordi e senza impronta.
Ei fu colui che urlava di un futuro
pur che ignorava, ma che adesso affronta,
andando incontro al fato perituro
di chi promette e dopo non mantiene,
per più non ritornar, quest’è sicuro”.