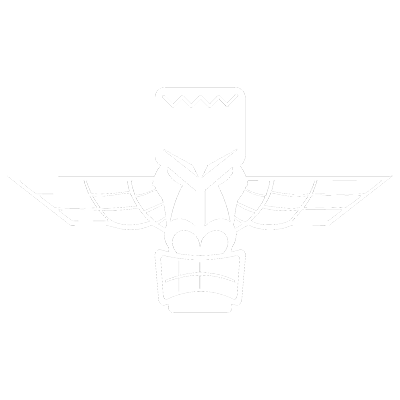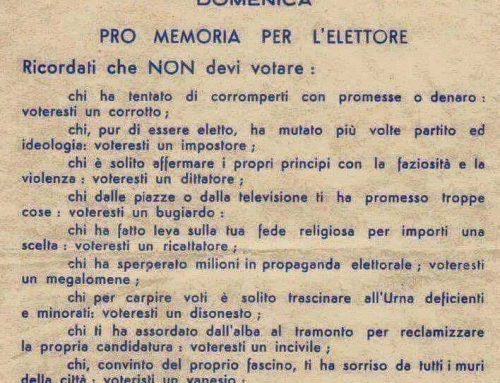È un dato di fatto: ogni volta che sento al telegiornale i raggelanti dati sulla disoccupazione dei miei coetanei mi sento come osservata. È come se mi sentissi addosso lo sguardo indagatore e sconcertato di chiunque fosse nato prima del 1968, cioè lo sguardo di chiunque sa di non dover scegliere a quale diritto fondamentale dell’uomo e del cittadino rinunciare per vedersi rinnovato il contratto. Io so infatti benissimo qual è la domanda che frulla ricorrente in testa a tutta questa gente: Ma quand’è che vi ribellate?
D’altronde è un assioma fondamentale della nostra vita: quando il popolo sta male dà di matto. Diventa nazista, diventa testimone di Geova, fa la rivoluzione, fa lo shatush, ma una cosa è certa: cambia radicalmente le cose. Noi invece no, nonostante l’affastellarsi di dati macroeconomici uno più tragico dell’altro rimaniamo così, placidi e rubicondi, come tante mortadelle al bancone della salumeria. In effetti anche io sotto sotto mi chiedo la stessa cosa. A forza di cercare invano di instillare in qualche modo una qualsivoglia coscienza di classe, sono finita a dover chiedere scusa alle pareti di casa mia. Non è vero che parlare di certe cose alla mia generazione è come parlare ai muri, perché persino i muri di casa mia, a forza di sentirmi parlare, si sono iscritti al fan club di Fiorella Mannoia.
Quindi il problema di fondo secondo me è che cerchiamo la risposta alla domanda sbagliata. La domanda da porgerci dovrebbe invece essere: Cos’è che vi impedisce di ribellarvi?
Perché allora sì che la risposta c’è e risiede nello Zeitgeist dell’epoca: il neoliberismo. No aspettate, lo so benissimo che l’ultima parola della scorsa frase promana pallosità da tutti i pori, ma qua non è solo una questione di una riduzione della presenza dello stato nelle politiche economiche di una nazione. Io qui parlo di un nuovo romanticismo che ha permeato le nostre vite e i nostri pensieri, indirizzandoci a fare determinate scelte di vita. Ebbene sì, basta con la solita pizza sulle delocalizzazioni, sullo strapotere di Wall Street o sugli operai cassaintegrati che, in collegamento dalla piazza, dicono le parolacce agli ospiti in studio di Michele Santoro: qui si guarda la cosa da un altro punto di vista, quello dei sentimenti. Perché se la natura è determinata dalle leggi della fisica, l’umanità è governata dalle leggi dell’economia, che è la più passionale delle scienze sociali.
Fateci caso: ogni teoria economica è sempre la rappresentazione matematica di un meraviglioso lieto fine. La produttività è sempre il frutto dell’incontro fatidico e ardente tra il lavoro e il capitale. Il consumatore, dopo mille traversie, trova prima o poi nel suo diagramma cartesiano il paniere di prodotti che lo corrisponde; la domanda e l’offerta di lavoro, non importa in che luogo o in che lago, ma finisce sempre che si incontrano e non si lasciano più. Tuttavia questo splendido romanzo Harmony sulla perfetta allocazione delle risorse non trova mai perfetto compimento nella realtà, perché nel mondo reale c’è sempre qualche suocera stronza, come per esempio lo stato, che s’impiccia sempre tra capitale e lavoro e dice loro cosa devono fare assieme e come lo devono fare; c’è il fisco che, come un destino malefico, frappone mille e mille ostacoli tra il consumatore e il raggiungimento del suo paniere; ci sono quegli zitelloni dei sindacati che a forza di continue pretese e prediche su tutto ucciderebbero qualsiasi unione, figuriamoci quella tra offerta e domanda del lavoro le quali, alla fine, si guardano stanche capendo che non ci sono più le condizioni per stare insieme e vanno via, in altri lidi, dove nessuno potrà osteggiare il loro incontro. Ecco, quindi basta accostare automaticamente la parola neoliberismo alla Thatcher che fa le pernacchie ai minatori o alle fabbriche di auto del Michigan che chiudono per continuare la produzione in Messico, perché non è questo il volto del neoliberismo che la mia generazione ha conosciuto.
Noi abbiamo conosciuto il suo volto passionale e sognatore, quello diffuso da studiosi, giornalisti e politici, secondo cui solo senza lacci, lacciuoli, regole e leggi tutti i fattori di economia avrebbero potuto realizzare i loro sogni come da sempre avviene nei manuali, e l’umanità assieme loro. Fiduciosi di questo destino, eravamo dunque sicuri che nulla avrebbe impedito alle nostre vite di avviarsi spedite verso quel paradiso in terra tante volte promesso dagli editorialisti dei maggiori giornali, un aldiquà chiamato Successo. Siamo venuti quindi su così, cresciuti da questa visione del mondo che appare così speculare rispetto agli striscioni e agli slogan sfoggiati nelle manifestazioni a cui andavano i nostri genitori, ritratto sgranato di un mondo che non c’è più. Noi non viviamo di lotte di classe, viviamo di amore. Nel mondo del lavoro neoliberista infatti non esistono acrimonia, invidia o vertenze sindacali. Vige solo una paradisiaca armonia dove tutti si vogliono bene e il datore di lavoro è un benevolo e affettuoso papà, sulle cui ginocchia il lavoratore sa di sentirsi amato e protetto dalle minacce che vengono al di là della saracinesca. Sì, nell’era neoliberista l’azienda ormai non è un triste luogo dove si viene schiacciati dalla gerarchie, ma una famiglia dove il lavoratore non ha più bisogno di combattere il padrone, ma – anzi – fa di tutto per vederlo sorridere. Siamo stati a lungo convinti dunque che la domanda e l’offerta di lavoro non dovessero essere costrette a stare insieme dalla legge, ma che si dovessero cercare, rincorrere continuamente come in Via col Vento, non importa se per un mese, un anno…
Qui si tratta insomma di capire che per noi non c’è spazio per i musi lunghi, i criticoni, gli orgogliosi, i nostalgici di un tempo che non tornerà. Sappiamo benissimo che il mercato del lavoro cerca candidati che non perdano tempo a frignare nelle assemblee sindacali perché nessuno li vuole, ma che sappiano gettare il cuore oltre l’ostacolo, ostinati nella ricerca di quel lieto fine tra domanda e offerta di lavoro promesso nelle teorie economiche. La disoccupazione insomma non è data dalla fabbrica delocalizzata in quei nuovi mercati resi interessanti dalle nuove leggi in materia di deportazione dei dissidenti; la disoccupazione per la mia generazione sei tu che non hai fatto nulla affinché la domanda di lavoro ti scegliesse. Se quest’ultima non viene da te noi proprio non ce la facciamo ad auspicare una società più giusta. Siamo stati infatti educati con l’idea di dimostrare di dovere soddisfare sempre e comunque questa benedetta domanda di lavoro, sfoggiando innanzi ai suoi occhi la lunghezza del nostro curriculum fatto di stage ed apprendistati, perché ormai nel mondo del lavoro le dimensioni contano eccome per dimostrare di saperci fare. E se non ce le hai per il neoliberismo sei come la mutanda nei film porno: superflua.
Noi possiamo dunque essere di destra, di sinistra o fregarcene altamente, ma è questo il sistema di valori in cui siamo cresciuti e che nessuna crisi o privazione riesce a scardinare perché noi non conosciamo altro. Matteo Renzi ci piace ma mica perché è così nuovo e giovane che non ho nemmeno il tempo di pensare un insulto per lui su Twitter che lui già mi risponde “Specchio riflesso, senza ritorno!”: ci piace perché il suo in realtà è un rassicurante lessico familiare, dove gli imprenditori sono sempre fighi, i sindacalisti sono pallosi e il tacco è dodici. Non c’è crisi che tenga: noi siamo e saremo soggiogati ancora dal neoliberismo e dal suo discreto fascino per cui la misura del valore di una persona è dettata dai complessi di inferiorità che riesce a scatenare negli altri. Ed è per questo che per la mia generazione il rosso stona su tutto, nonostante le vigorose ulcere anali.