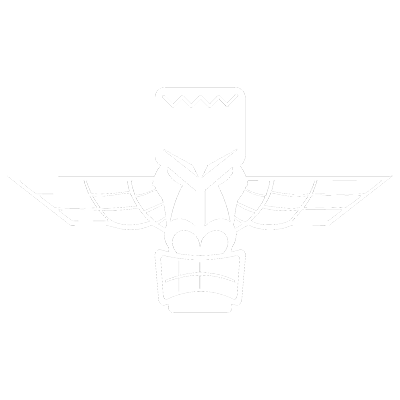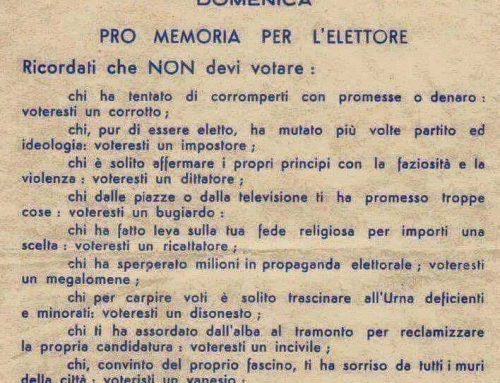Sono tante le cose che mia mamma non capisce di me. Per esempio non capisce che senso abbia avuto iscrivermi al liceo classico indirizzo figli di papà se poi ho lo stesso reddito pro capite di una diplomata al professionale, indirizzo shampiste in nero. Quello che però maggiormente le sfugge di me è il mio così completo trasporto nei confronti di Cristina D’avena.
Come dare torto però alle sue perplessità? Mia madre vede in tv una quasi cinquantenne cantare a squarciagola nelle piazze È un po’ magia per Terry e Maggie, senza che questa descrizione corrisponda a quella di una barbona tossicodipendente, mentre per me è una sorta di divinità giunta tra noi per realizzare la dittatura del proletariato così come Marx la immaginava. La domanda è dunque pertinente: cos’è che rende Cristina D’avena un tale fenomeno? Che si tratti del locale hipster frequentato solo da gruppi indie – grazie a Dio di scarso successo – o del centro commerciale costruito per coprire una discarica di rifiuti tossici, tutti i Suoi concerti sono sempre sentiti e partecipati come fossero delle messe laiche, in cui il Suo verbo è ogni sera annunciato da gnomi, gemelli del destino, orfanelle, guerriere e nazionali della pallavolo.
Credo personalmente che la risposta risieda nel fatto che Cristina D’avena rievochi in noi il ricordo di un’epoca che non c’è più, basata su tante rassicuranti certezze, come per esempio lo stipendio a fine mese, o i cartoni animati alle quattro del pomeriggio. Accendevamo la tv puntualissimi all’orario stabilito e subito venivamo catapultati dalla voce di Cristina in uno sgargiantissimo mondo fatato, dove il bene vinceva sul male: il mondo dei cartoni animati giapponesi. Certo, mi si dirà a questo punto che anche nei cartoni della Disney tutte queste cose ci sono sempre state, ma se nessuno ha nostalgia di questi ultimi è perché i cartoni americani hanno sempre avuto le trame smorzate da un gigantesco superego cristiano, cosa che li rendeva decisamente meno arrapanti rispetto a quelli giapponesi. Voglio dire: in Cenerentola le sorellastre volevano vedere la protagonista messa carponi sul pavimento a pulire; in Georgie i fratellastri volevano vedere la protagonista messa carponi e basta.
Comunque sia, se si torna indietro con i ricordi, è impossibile che non salga un polpo alla gola nel momento in cui si rammenta quello che vivevamo in quei lontani e bellissimi pomeriggi. Noi ancora non immaginavamo quanto un giorno avremmo desiderato ruttare, almeno una volta, tutti quei calici amari ingoiati pur di campare. Pensavamo infatti che la vita fosse facile perché nella tv che guardavamo ogni cosa diventava possibile: per esempio poteva accadere che la ragazzina più sorridente, buona, generosa, disponibile e amata dal prossimo venisse messa sotto da un camion come in Pollyanna; oppure che alla ragazza che non ti si fila di pezza crepasse il fidanzato nel giro di una puntata come in Prendi il mondo e vai; o anche che un’orfana stracciona del Michigan come Candy Candy venisse improvvisamente adottata da un uomo ricchissimo che poi se la rimorchia pure, senza che ci fosse in questo caso Mia Farrow con qualcosa da ridire a riguardo.
Noi all’epoca non potevamo sapere cosa fossero i soffitti di vetro, le scale mobili sociali bloccate o altre metafore dell’Architectural Digest sociologico, perché chiunque in tv al pomeriggio poteva ritrovarsi: insomma, solo in Petali di stelle per Sailor Moon le transessuali salvano l’universo; solo in Mimì e la nazionale della pallavolo la protagonista per vincere ha l’idea di farsi legare tutta sudata con delle catene, senza che l’allenatore avesse qualcosa da obbiettare, o tra le mani. Insomma, come potevamo prevedere che non ci sarebbe stato il lieto fine per noi, quando quello che vedevamo era così puro e privo di malizia? Voglio dire, Marrabbio in Kiss me Licia non doveva pagare il pizzo alla ‘ndrangheta per tenersi il ristorante. Jem e le Holograms dovevano il loro successo ad un paio di orecchini, non a Maria de Filippi. Una per tutte / tutte per una / vieni anche tu / e saremo una in più era un verso della sigla del cartone di Piccole donne, non il testo di un sms mandato da Nicole Minetti a Barbara Faggioli.
Oggi al massimo ci ritroviamo la sera in qualche locale aperto da dei giovani che non volevano arrendersi alla mancanza di lavoro e hanno deciso di inventarsene uno, magari bevendo una birra artigianale prodotta da dei giovani che non volevano arrendersi alla mancanza di lavoro e hanno deciso di inventarsene uno. Dapprima sgraniamo i nostri personali rosari di contratti scaduti, colloqui scassati, stipendi evaporati, ma alla fine ci ritroviamo a sdrammatizzare spesso e volentieri ricordando quelle sigle, quei pomeriggi passati nella sicurezza che qualsiasi strada da noi intrapresa ci avrebbe portato a destinazione, non sulla Salerno-Reggio Calabria a Ferragosto.
Così, quando Cristina D’avena giunge nelle nostre città, noi non ci accalchiamo adoranti per caso. Noi ci stringiamo attorno alla nostra personale divinità, ne assistiamo al culto, durante il quale tramite i Suoi canti evochiamo il ricordo della Terra Promessa da cui la maggiore età ci ha scacciati. A Lei ci appelliamo affinché un giorno l’Esodo nel deserto delle prospettive si concluda con il ritorno nella Terra dove scorre latte e Nesquik, e lo facciamo cantando le sigle a pieni polmoni sotto a quel palco, per dimenticarci una sera soltanto che la nostra vita sempre sempre così sarà, come per Mila e Shiro, sì.