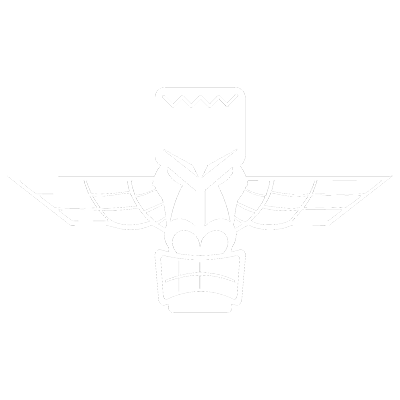– «Mi spiace, è stato un inverno rigidissimo».
Lo dice come se fosse dipeso in qualche modo da lui, come quando qualcuno era a Palermo e pioveva e io mi sentivo in qualche modo responsabile del clima della mia città.
– «Forse è stato il peggiore inverno che io abbia mai visto qui, assieme a quello dello scorso anno», aggiunge. Lui è newyorkese d’adozione, venuto a lavorare qui, come quasi tutti, eppure il senso di appartenenza lo porta a identificarsi con la città. «I’m a newyorker», potrebbe dire e avrebbe pienamente senso, visto che la città è questo coacervo di tessuto umano differente, proveniente per davvero da ogni angolo del mondo.
– «È una delle città dove si mangia meglio al mondo», dico, provando a giocarmi la carta cibo per trarlo fuori da quel reale sentimento di scuse nei confronti del meteo. Arrivano i piatti, intanto. Mangio una bruschetta di bresaola su un letto di fave, lui una zuppa di lenticchie. Decisamente buone entrambe le portate.
Ci salutiamo e io penso che però è incredibile come sia possibile qui avere questa orizzontalità nei rapporti professionali con persone considerate, giustamente, dei mostri sacri. In Italia invece è tutto improntato a una verticalità opprimente, che viene sempre fatta pesare: è il Paese della gerarchia, del «lei non sa chi sono io». Qui no. Qui è business, se dovessimo ridicolizzare il tutto a un unico slogan che si avvicini il più possibile al cuore delle cose.
C’è questo, di New York. Andrea, professionista nel mondo della moda, lavora qui da cinque anni, dopo una esperienza triennale a Londra. Giudica New York come «la città più schizofrenica del mondo, bellissima, una moltitudine di persone che portano usi e costumi diversi e alla fine tutti pensano solo al profitto, lavoro, lavoro, lavoro. Alla lunga è logorante perché mancano i rapporti umani in profondità, è tutto capitalismo spinto all’ennesima potenza».
Non è il primo abitante della City che mi dà questo parere. NY è stupenda, conoscere persone è semplicissimo – mi dicono in tantissimi residenti – ma è come fare surf sulla superficie del mare, non c’è mai l’immersione in profondità.
– «È il posto ideale per lavorare», taglia corto Silvia.
Al Medical Care, una sorta di pronto soccorso, sto compilando il modulo per l’accettazione. Silvia ha bisogno di un antibiotico e nelle Pharmacy viene dato solo su prescrizione medica. La sola accettazione – cioè il solo compilare il modulo per finire davanti al personale – costa 125 dollari.
Due ragazzi alla mia sinistra discutono ad alta voce del mercato immobiliare della città.
– «Adesso divido la casa con un avvocato», sta dicendo quello con evidenti origini asiatiche.
– «È dura, io prima a Seattle vivevo da solo, la stanza mi costa 2200 dollari.»
– «Spese incluse?»
– «Escluse. Infatti con la mia compagna non ce la facciamo, appena ci sposiamo andremo altrove, Jersey City, credo.»
New York ha dei prezzi riguardo il mercato immobiliare definiti folli da alcuni, vergognosi da altri, fuori dalla grazia di Dio dal restante numero di abitanti. È la città al mondo con il più alto numero di single, più del 60%.
– «I soldi sono il metro di tutto», dice il ragazzo di colore all’amico all’asiatico.
– «Tu quanto paghi di assicurazione medica al mese?»
– «800 dollari.»
– «Sei coperto, quindi?»
– «Puoi scommetterci.»
Dall’accettazione ci fanno segno che la visita di Silvia è pronta. Il personale è gentilissimo. Ci accoglie una infermiera di origine italiana che controlla la temperatura di Silvia (101.8 in scala Fahrenheit, 38.7 in Celsius, altina ma è nulla rispetto al 104 di partenza, il quarantone bello tondo che Silvia aveva quando ci muovemmo da casa –in ogni caso, sia sempre benedetta la tachipirina, in saecola saecuolorum, amen), poi le controlla la pressione. Si dà il cambio con un infermiere, minuto, affabile, meticoloso, d’origine irlandese. Facciamo il test per l’influenza (50 dollari), poi quello per le placche alla gola (25 dollari, risultato vincente, ma noi lo sapevamo già da prima e lo facemmo pure presente che di placche alla gola si trattava, ma una volta lì, in quelle camere piccole piene di gentilezza, se mi avessero chiesto «Volete fare il test per la possibilità di viaggiare nel tempo? Costa solo 3000 dollari», avrei risposto affermativamente. Avrei risposto di sì a tutto. È meglio non avermi come accompagnatore in queste circostanze). Fa il suo ingresso in scena il dottore, sembra hawaiano. Come nei film, porge a Silvia un contenitore di plastica trasparente pieno di pillole mentre l’infermiere le dà un bicchiere d’acqua. Silvia trangugia le pillole, ibuprofene e antibiotico. La prescrizione dell’antibiotico intanto è finalmente nelle mie mani, dopo che il medico si è premurato di rassicurarmi per ben tre volte che le medicine appena assunte da Silvia erano gratis. Non c’è problema, avrei voluto rispondere, piuttosto ecco i tremila testoni, dov’è la macchina del tempo? La struttura è linda, l’anamnesi medica è stata condotta con scrupolo, Silvia sta già moooolto meglio. Torniamo a casa su un taxi guidato da un indiano.
Compare, finalmente il sole. Erano anni che non si vedeva il sole. Un inverno durato per davvero una intera interminabile, gelida stagione. I playground cominciano a popolarsi. Incontri di basket e baseball, partite di pallone, attività ginnica nei parchi. Capisco per la prima volta nella mia vita il bisogno fisico del sole. Meno venticinque gradi segnano, sono una cicatrice indimenticabile. Tre mesi sotto zero, devastano. Infatti NY tutta pare essersi risvegliata da un letargo. È alla lettera un’altra città, decisamente più bella, perché porta il suo vero tesoro, il capitale umano, per le strade, a interagire. Camminando, trovo un punto che mi mozza il fiato e che innalzo all’istante a mio luogo preferito della città, l’East River State Park a Williamsburg. La vista della foto è quella che si gode da qui. Bambini giocano, adulti passeggiano il cane, coppie si baciano sulla sabbia, Manhattan è là davanti, e sembra davvero che fiume segni un confine, il luogo del lavoro da quello del tempo privato, secondo una visione manichea e semplicistica che, in qualche modo, appartiene un po’ (tanto) all’anima di ‘sto luogo.
– «Com’è, mi chiedi. È stupenda, ma questo lo sostenevo fin da subito», dico a Sandro su Skype.
– «Però non posso che concordare con Silvia. È una città priva di erotismo. Ed è un peccato, perché io ne sono profondamente innamorato. Ma non è languida, c’è troppa frenesia, troppa corsa e zero tempo per il ritmi lenti di cui ho bisogno.»
– «Quando parti?»
– «A giugno.»
– «Ci ritornerai?»
– «Non vedo l’ora.»
– «Ma hai appena detto…»
– «Lo so cosa ho detto. Però…»
– «Però cosa?»
– «Però è un luogo cambia sempre. È viva, e c’è una energia incredibile.»
Lo saluto, dò una carezza e Pepa e scendo. C’è il sole e mi dirigo a Coney Island.